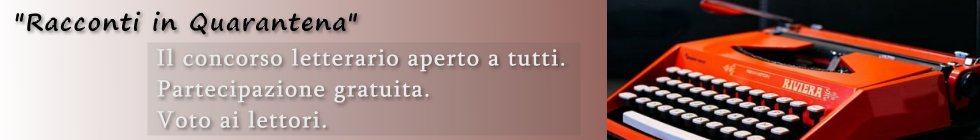Suona il telefono, mancano due ore all’inizio del turno di notte.
La divisa è pronta, appoggiata sulla sedia.
E’ un collega che mi chiama, con quel tono di supplica che ormai conosco e a cui non so dire di no. Il nostro lavoro ruba molto tempo alla famiglia, spesso non riusciamo ad essere accanto ai nostri famigliari proprio nel momento del bisogno e, quando a chiedere aiuto è tuo figlio ti si spezza il cuore: “Il mio bambino ha la febbre, sono in ritardo, puoi coprirmi per mezz’ora?”.
Sono già pronta.
Mi stavo preparando per la fase Pre Turno, come la chiamo io. Metto il telefono in modalità silenzioso, evito così distrazioni, ripasso lentamente gli ultimi interventi fatti, i sintomi e i volti dei pazienti e mi chiedo sempre se ho tralasciato qualcosa, se avrei potuto fare meglio.
Parto.
Attraverso la città, che sembra inghiottirmi con i suoi semafori rossi, trattengo il fiato fino al ponte del Po, dove inizio a respirare e a cibarmi di quel tramonto che non mi delude mai, di quella timida campagna che in primavera mi offre i suoi profumi.
Sono una donna e sono un soccorritore. Il mio mestiere è salire in ambulanza e affrontare le emergenze, ma da sessanta giorni non è più così. Tutto è cambiato. Oggi, sopra la mia divisa, indosso una tuta bianca, che nella notte mi identifica come un fantasma, perché mi copre tutto il corpo, la sua cerniera si chiude proprio sotto la mia gola e il cappuccio mi copre capelli e fronte, rimane scoperto il viso che copro minuziosamente con mascherina e visiera. Sulle mani doppi guanti, quelli blu, quelli pesanti e resistenti, che incastro con attenzione sopra le maniche. Il rito della vestizione deve essere fatto con molta attenzione, nessuna parte del corpo deve essere esposta, ho la sensazione di indossare una seconda pelle che avrà lo scopo di proteggermi. Non voglio specchiarmi, perché ho paura di spaventarmi, di intravedere nei miei occhi, quel terrore che vedo negli occhi degli ammalati.
Il telefono suona, questa volta non è il mio, è quello della centrale operativa. “C’è una chiamata per voi “ annuncia l’infermiera dall’altro capo..
“Covid “.
Via si parte. In quel momento mi sento un “Supereroe”, ho l’adrenalina che mi scorre nel corpo perché posso salvare una vita, anche se è notte fonda non ho sonno, non ho freddo e tutto mi appare chiaro. La mia mente ha la capacità di azzerare , lascio la mia vita giù dall’ambulanza, per entrare nella vita degli altri. La mia squadra è formata da tre elementi,un autista-soccorritore e due soccorritori di cui un leader. Trascorriamo insieme migliaia di ore, ci conosciamo a tal punto che basta uno sguardo per comprendere ciò che l’altro pensa. La complicità con il tuo equipaggio la conquisti col tempo, condividi tantissime emozioni, vedi passare di fronte a te la morte, come un fiume in piena che straborda dal suo letto, leggi negli occhi di un bimbo la gratitudine, quando lo estrai dall’abitacolo di una macchina,stringi la mano di un anziano che non ha nessuno al mondo. Ecco, questo è il mio lavoro, specchiarmi negli occhi sofferenti di chi ha bisogno, cercare di cogliere quel particolare, quella parola non detta, per capire che necessità c’è e correre, correre, nel traffico della sera a sirene spiegate per salvare una vita.
Quando arrivo, il paziente spesso è spaventato e la sua famiglia sempre tanto agitata.
Io, che nemmeno ci vedo attraverso queste protezioni che indosso, devo stare attenta a dove metto i piedi, per non inciampare, mi arrampico sulle scale e dopo dieci gradini inizio a sudare con questo “scafandro” che indosso.
Quasi rovinosamente, evitando ostacoli come seggiole e tavoli, entro nella stanza, spesso la camera da letto. Non riesco a parlare perché la mascherina mi stringe così forte il naso che mi fa male da impazzire e la poca aria che passa mi appanna la visiera. Devo annullare me stessa e pensare a chi sta male, ma ancora non ci riesco, perché mentre i parenti mi descrivono le criticità della situazione, io sto guardando le fotografie che sono sul comodino, il giorno del matrimonio, la laurea dei figli e quelle medaglie incorniciate, appese al muro, ricordi dei momenti più belli della vita, ricordi rubati ad attimi di serenità.
Mi concentro sui parametri, temperatura elevata, troppo elevata, respiro affaticato, nessuna percezione dell’olfatto e del gusto, c’è qualcosa che non va. Decido per il trasporto in ospedale. Questo virus è un mostro, è imprevedibile, ti annienta, ti toglie la forza di parlare, di respirare, perdi la padronanza di te stesso e in poco tempo..muori.
Chiedo alla famiglia un cambio di vestiti e il numero di telefono, perché nessuno potrà andare a trovarlo in ospedale, nessuno potrà portargli una parola di conforto, nessuno potrà regalargli un sorriso. Nella notte, in mezzo a quella bassa foschia, tipica delle notti della padana, attraverseremo la campagna e raggiungeremo l’ospedale. Ci siamo lasciati alle spalle i volti delle persone attonite e spaventate nel vedere quei fantasmi bianchi, nella loro casa.
Per i prossimi venti minuti siamo noi e lui . Quel breve viaggio è colmo di interrogativi, scende una lacrima sul volto del mio paziente. Il mio collega mi fa un cenno e mi sussurra: “ Invertiamo i posti, io compilo la scheda anagrafica e tu siedi di fianco a lui e provi a tranquillizzarlo “. E’ il responsabile del turno, sono cresciuta con lui, mi ha insegnato tutto, si è sempre stupito della mia infinita curiosità di imparare, si fida di me. Non è facile, dentro questa imbragatura, essere se stessi, ci provo. Mentre ti trasportano in ambulanza, sei caricato al contrario e spesso provi la sensazione di dover vomitare, lo so perché capita anche a me, allora prendo la mano del mio paziente e cerco di trasmettergli la mia calma, lui mi guarda incredulo, come può fidarsi di me ?, vede solo due grandi occhi marroni. Mi torna alla mente un episodio della mia vita e glielo racconto.” Durante uno dei miei viaggi, mi è capitato di attraversare l’oceano in barca, interminabili ore in mare aperto, trascorse solo per vedere i delfini salutarmi. Ricordo che lo stomaco si era spostato al posto della bocca e minacciava di uscire, un’amica mi ha detto :chiudi gli occhi, ti aiuterà a rilassarti e passerà . Ha funzionato. Ora, per un istante chiudiamo gli occhi e immaginiamo di trovarci in mezzo a quell’oceano, aspettiamo il canto dei delfini. Sono certa che passerà.
Il mio paziente si è addormentato, respira meglio, mi stringe così forte la mano che non riesco a muovermi, ho paura di svegliarlo. In questo istante, tutto può aspettare, rinchiudiamo per un attimo fuori la paura , lasciamola per strada, perché ho paura anch’io. Paura che questo virus mi entri in bocca e che attraversi i miei polmoni, paura di infettare la Giuly, la mia dolce e anziana mamma che mi aspetta a casa. Paura di perdere la vita, di non rivedere più l’alba, il mare. Paura di non sentire più la mia canzone preferita, paura di non avere più tempo per dire ti amo. Arriviamo in Pronto Soccorso, un altro viaggio, un altro paziente.
E’ trascorsa la notte, quasi non me ne sono accorta, corro a casa per farmi una doccia, mi sento sporca, sporca di quell’invisibile visitatore unto che si è infilato nella nostra vita, insinuato nei nostri pensieri.
E’ pomeriggio, ho riposato un po’, la Giuly mi aspetta in cucina per il caffè, non sente ragione. Ha accettato tutto, cenare separate, dividere la casa, perché io potrei essere infetta, ma il caffè delle cinque è un appuntamento, a cui non si rinuncia. Ci sediamo lontane, due metri di distanza e ci raccontiamo le nostre reciproche giornate. Lei scalpita, vuole uscire, vedere le amiche del corso di pittura, inganna il tempo dipingendo da casa, è in gamba la Giuly, non molla mai. Io ritorno ad essere per qualche minuto la sua piccola figlia, desiderosa di ascoltare quei racconti della sua infanzia, quando la famosa “ influenza spagnola” imperversava per le strade dell’Italia. “ A quei tempi “ dice lei “ non esistevano queste strutture ospedaliere così all’avanguardia, si moriva per strada. Gli ammalati erano confinati nelle Chiese o nelle grandi ville, adagiati per terra, affidati a Dio. Gli unici, chiamati a rischiare la vita per curarli, senza mascherine e senza protezioni, erano i Frati ”. Poi, mi parla della guerra, dei terribili anni trascorsi a nascondersi nei rifugi e dell’arrivo degli Americani, di quegli uomini così gentili che regalavano noccioline a tutti, di quando i bambini venivano fatti salire sui carri armati, trionfanti, come se la guerra l’avessero vinta loro. Gli Americani, gli stessi che oggi hanno innalzato un ospedale da campo nel parcheggio dell’ospedale, non portano noccioline, ma respiratori, ecografi e tanta umanità. Gli stessi che esultano la sera all’arrivo della pizza, regalata dai ristoranti della città. Forse quell’umanità assaporata durante la guerra, la ritroviamo questa sera, quando improvvisamente, sul tetto del’ospedale compare una ragazza vestita di rosso che suona uno Stradivari. Mentre cala il sole e un’altra giornata di quarantena è trascorsa, mentre la Giuly beve il caffè, mentre io raccolgo i miei pensieri, mentre i pazienti combattono per sopravvivere, mentre medici e infermieri trascurano le famiglie, i figli. Mentre non possiamo andare in Chiesa, il virus ,sornione passeggia, con le braccia giunte dietro la schiena, ci mette alla prova. Così come lo dipingono i bambini.
E’ sera un’altra volta, un altro turno, un’altra storia, ma se per ogni carezza fatta ad un ammalato è una carezza per Dio, a me basta questo.
Forza Cremona. Rinasceremo.
I vecchi torneranno a passeggiare mano nella mano, riempiremo questa città troppo vuota, torneremo a camminare su quei Sanpietrini che circondano il Duomo, troppo soli, senza lo scalpitio dei bambini ed il vociare delle mamme che ancora, prenderanno il gelato urlando : ”non correte”.Tornerà il suono di quel violino che dall’ultimo gradino del Torrazzo, mentre il sole beffeggiando tramontava ha vibrato sulla città deserta..Mentre accendo ancora le sirene, provo una grande emozione, il Supereroe è tornato donna e il mostro non ha vinto.
— 0 —
» vota il tuo racconto preferito » vai alla presentazione del concorso » leggi tutti i racconti arrivati